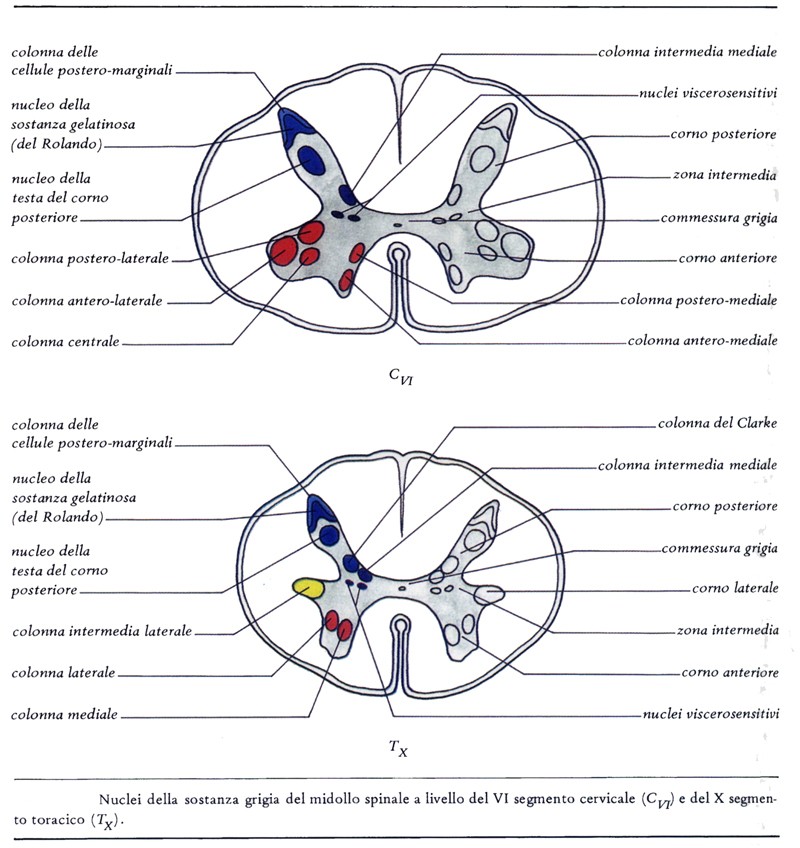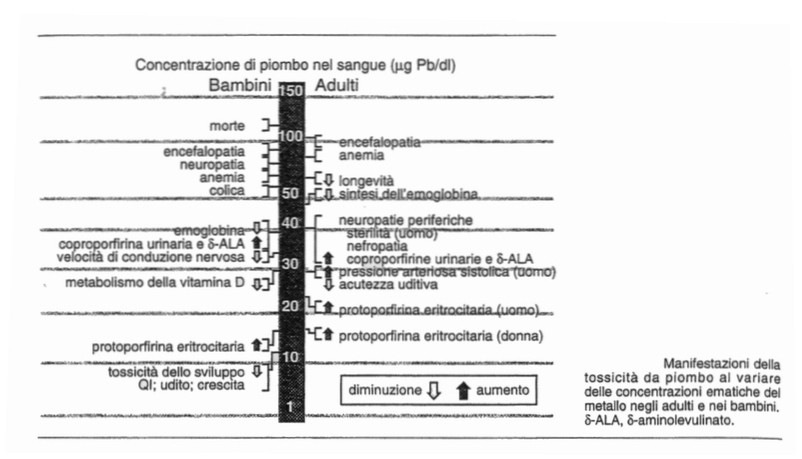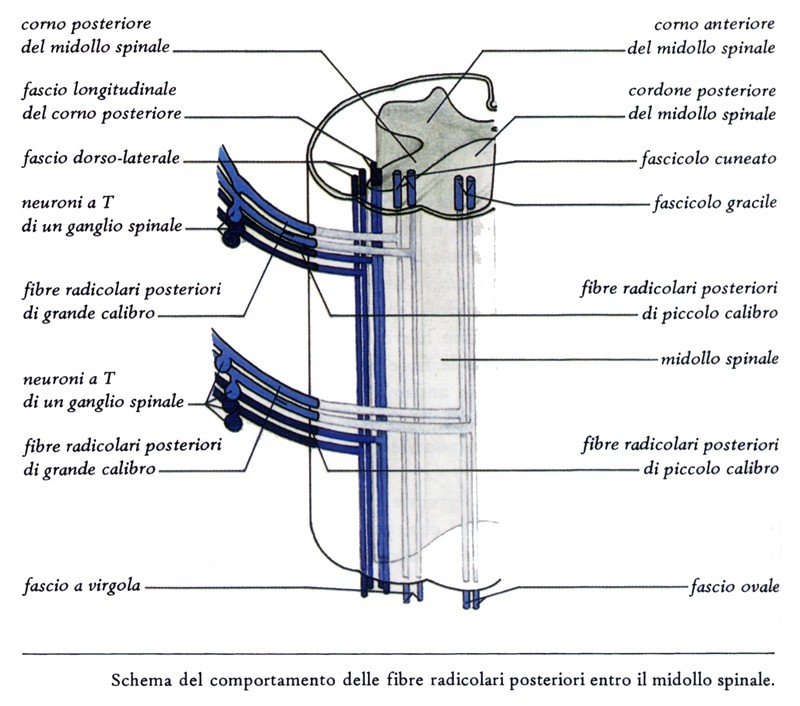Senza categoria
Anomalie di posizione dell’utero
Prima di considerare le anomalie di posizione dell’utero, bisogna ricordare che normalmente l’utero si trova in posizione di antiverso-flessione, cioè l’organo, nel suo insieme, è inclinato in avanti rispetto all’asse della vagina con un angolo di circa 90-100° e l’asse del corpo è flesso su quello del collo con un angolo aperto anteriormente di 120-170°. In condizioni non del tutto fisiologiche, l’utero può presentare spostamenti anteriori o posteriori. Gli spostamenti anteriori rappresentano un’esagerazione della posizione normale dell’organo; si parla di: Antiflessione, quando l’utero è ripiegato su se stesso, descrivendo un angolo acuto tra corpo e collo. Antiversione, quando l’utero è interamente spostato in avanti formando un angolo acuto con la…
Biofeedback elettromiografico
Il biofeedback elettromiografico è una tecnica che utilizza un elettromiografo di superficie collegato ad un sensore endovaginale. In questo modo, la paziente ha una visione di ritorno di quello che sta facendo e quindi ha la possibilità di vedere se esegue correttamente l’esercizio affidatogli dal terapeuta ed eventualmente di correggersi. La finalità della terapia è consentire alla paziente d’imparare a controllare la muscolatura pelvica, riducendo progressivamente l’ipertono che la caratterizza.
Anatomia sistematica
L’anatomia sistematica è una branca dell’anatomia che studia gli organi del corpo umano, descrivendone situazione spaziale, forma, rapporti, vascolarizzazione e innervazione. Articolo creato il 31 marzo 2011. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.
Betanecolo
Il betanecolo è un estere sintetico della colina, quindi un farmaco parasimpaticomimetico diretto. Differisce strutturalmente dall’acetilcolina (ACh) per la presenza di un gruppo amminico (-NH2) oltre ad avere un gruppo metilico sul carbonio α. Meccanismo d’azione del betanecolo Il betanecolo agisce legandosi ai recettori colinergici muscarinici. Proprietà farmacologiche del betanecolo Sono quelle tipiche dei parasimpaticomimetici ma ha un’azione principalmente muscarinica, con una selettività per la motilità del tratto gastrointestinale e della vescica. Esso determina ipotensione transitoria alle dosi necessarie per ottenere gli effetti gastroenterici e urinari. Apparato cardiovascolare: vasodilatazione, effetti cronotropo, inotropo e dromotropo negativi. Apparato gastrointestinale: aumento del tono, ampiezza e contrazioni più aumento dell’attività secretoria di stomaco e…
Pompa calcio-ATPasi
La pompa calcio-ATPasi è rappresentata dalla pompa del calcio della membrana plasmatica (PMCA) e dalla pompa del calcio del reticolo sarcoplasmatico (SERCA) che hanno lo scopo di estrudere ioni calcio. La pompa Ca++-ATPasi, insieme al cotrasportatore (antiporto) 3Na++-Ca++, fa parte dei meccanismi OFF del calcio. Pompa del calcio della membrana plasmatica (PMCA) Ne esistono quattro isoforme e sono attivate dalla calmodulina; ha il compito di pompare uno ione calcio dal citosol all’esterno. PMCA 1: ubiquitaria, ha la funzione di mantenere costante la concentrazione intracellulare di calcio. Presenta un sito per la fosforilazione da parte di protein-chinasi A e C (PKA e PKC) (che serve ad aumentare la velocità della pompa).…
Stimolatore elettrico transcutaneo dei nervi (TENS)
Lo stimolatore elettrico transcutaneo dei nervi (TENS = transcutaneous electrical nerve stimulation) è una tecnica che prevede l’applicazione di uno stimolo elettrico nei confronti delle terminazioni nervose sottocutanee; in relazione ai parametri utilizzati (ampiezza e durata dell’impulso) è possibile agire sulle terminazioni nervose attraverso un meccanismo neurofisiologico mirato.
Terminologia anatomica
Quando si descrive un organo o una parte del corpo è importante tenere a mente dei termini che possano descrivere al meglio ciò che si sta valutando, cercando di creare meno confusione possibile. Genericamente possiamo considerare i termini di posizione e i termini di movimento. Entrambi i termini si riferiscono al soggetto in stazione eretta, con gli arti superiori posti ai lati del tronco e le palme delle mani rivolte all’osservatore. Termini di posizione Sono definiti tali quei termini che caratterizzano la situazione di una qualsiasi parte del corpo; con parole più semplici s’intende stabilire se una parte del corpo si trova avanti, dietro, sopra, sotto, ecc. rispetto ad un’altra…
Cellule dell’organismo
Nell’organismo sono presenti circa 200 tipi di cellule, ognuno specializzato in particolari funzioni e quindi con particolari caratteristiche strutturali. Articolo creato il 29 luglio 2011. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.
Sistema immunitario
Il sistema immunitario è l’insieme delle cellule e delle molecole responsabili della protezione dell’organismo da microbi o altre macromolecole estranee. La difesa nei confronti dei microbi poggia su risposte precoci mediate dall'immunità innata (o naturale) e su risposte più tardive mediate dall'immunità specifica (o acquisita). Le cellule responsabili della risposta innata sono i granulociti neutrofili, i macrofagi e i linfociti natural killer (NK); l’immunità innata, inoltre, presenta anche altri meccanismi di difesa (barriere chimico-fisiche dell’organismo, proteine).
Purganti
Il razionale d’uso di un purgante osmotico consiste nel minimizzare l’assorbimento accelerando il transito dell’agente tossico nel tratto gastrointestinale. Essi sono in genere considerati sicuri, a meno che il veleno non abbia danneggiato la parete del tratto gastrointestinale. I purganti sono indicati dopo l’ingestione di compresse rivestite gastroresistenti, quando sia trascorsa almeno un’ora dall’ingestione, e per gli avvelenamenti da idrocarburi volatili. Il sorbitolo è il più efficace, ma vengono utilizzati anche il solfato di sodio e il solfato di magnesio; hanno tutti un’azione veloce e solitamente una bassissima tossicità. Il solfato di magnesio, tuttavia, deve essere somministrato con cautela a pazienti con insufficienza renale o a soggetti predisposti a sviluppare…