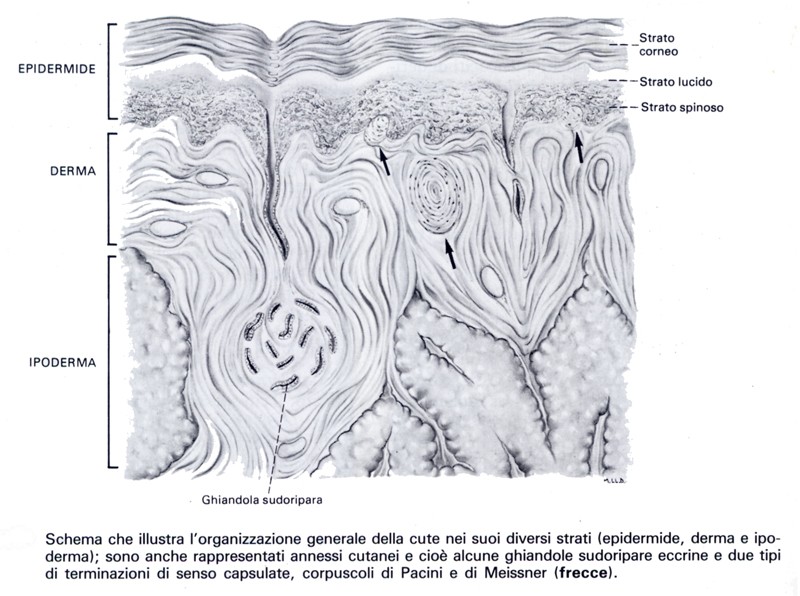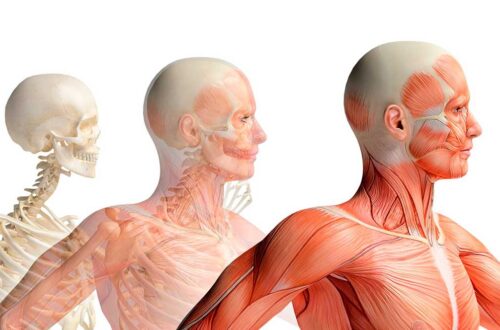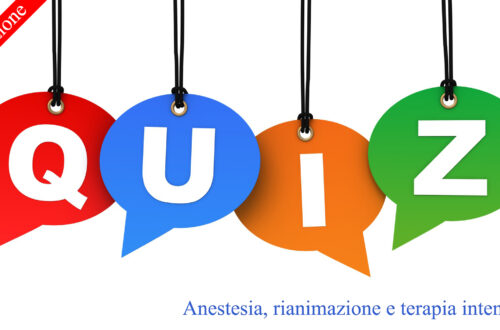Miometrio
Il miometrio rappresenta la tonaca muscolare dell’utero; è notevolmente spessa ed è costituita da fasci di fibrocellule muscolari lisce, intervallate da uno stroma fibroso relativamente abbondante. Nel miometrio si distinguono tre strati: Lo strato interno (o sottomucoso) è costituito da fasci muscolari a decorso prevalentemente longitudinale che si dispongono ad anello attorno allo sbocco delle tube. Lo strato medio (o vascolare od emostatico) è costituito da fasci ad andamento circolare od obliquo, disposti a circondare le diramazioni vascolari; questo strato è anche definito vascolare od emostatico perché la sua contrazione causa un’occlusione del lume dei vasi che lo attraversano, di fondamentale importanza per arrestare l’emorragia dopo il secondamento (la fase…
Nuclei ipotalamici neurosecernenti
Nell'ipotalamo sono situati raggruppamenti di cellule nervose nei cui pirenofori vengono prodotte sostanze di tipo ormonale. Questi raggruppamenti neuronici sono definiti nuclei neurosecernenti e il materiale da essi elaborato viene genericamente chiamato neurosecreto. Si distinguono due gruppi principali di nuclei neurosecernenti: nuclei magnicellulari e nuclei parvicellulari. I nuclei magnicellularisono rappresentati dal nucleo sopraottico, posto al di sopra del chiasma dei nervi ottici e dal nucleo paraventricolare, localizzato in corrispondenza della parete infero-laterale del terzo ventricolo.
Bombesina
La bombesina è un polipeptide a 15 aminoacidi che ha un effetto eccitante sulla motilità intestinale e sulla secrezione gastrica e pancreatica esocrina. È prodotta dalle cellule P che hanno granuli piccoli (100-140 nm), dotati di debole argirofilia. Le cellule P si trovano, poco numerose, nella mucosa dello stomaco e di tutto l’intestino, con la maggiore concentrazione nell’antro pilorico e nel duodeno. Articolo creato il 15 agosto 2011. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.
Enzimi a funzione recettoriale
In farmacologia sono considerati recettori non solo i recettori veri e propri ma qualunque altra struttura o molecola che può essere bersaglio di farmaci. Anche gli enzimi, quindi, possono essere considerati recettori. Esempi di enzimi a funzione recettoriale possono essere fatti considerando: Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) Sono farmaci che hanno come bersaglio specifico l’enzima ciclossigenasi, che è l’enzima chiave nella cascata dell’acido arachidonico da cui si formano leucotrieni (LT), trombossano (TXA2) e prostaglandine (PG); l’aspirina (acido acetilsalicilico), è un inibitore irreversibile dell’enzima ciclossigenasi esercitando così la sua funzione di antinfiammatorio. ACE-antagonisti Sono usati nel trattamento dell’ipertensione; l’ACE trasforma l’angiotensina I in angiotensina II che ha effetti a livello vasale…
Arteria carotide interna
L’arteria carotide interna, che si distribuisce all’encefalo e agli organi dell’apparato della vista, nasce dall’arteria carotide comune all’altezza del margine superiore della cartilagine tiroidea della laringe e si dirige in alto e in dietro, risalendo fino a raggiungere l’orifizio inferiore del canale carotico dell’osso temporale. Percorre il canale, seguendone le curvature, ed emerge dall’orifizio superiore del canale stesso, penetrando così nella cavità cranica; si porta quindi all’interno del seno cavernoso, entro il quale decorre con un tragitto a S. Giunta all’altezza del processo clinoideo anteriore, l’arteria diventa verticale e perfora la dura madre. Qui fornisce una voluminosa collaterale, l’arteria oftalmica, quindi termina, al di sotto della sostanza perforata anteriore dell’encefalo,…
Recessi cecali
Tra i recessi cecali vanno ricordati quello ileocecale superiore, quello ileocecale inferiore e quello retrocecale. Il recesso ileocecale superiore si presenta, nell'adulto, di dimensioni piuttosto ridotte; esso ha per limiti, in avanti, la cosiddetta piega vascolare del cieco (che contiene i vasi per la giunzione ileocecale), in dietro il mesentere, a sinistra il tratto terminale dell'ileo e a destra la giunzione ileocecale. La sua apertura guarda in basso e a sinistra.
Modello a mosaico fluido
Secondo il modello a mosaico fluido, la struttura delle membrane è costituita da un doppio strato di molecole lipidiche (con spessore di 7-8 nm). I lipidi del doppio strato sono anfipatici, cioè sono molecole con caratteristiche sia idrofobiche che idrofile. Le regioni idrofobiche, concentrate nella parte interna delle membrane, costituiscono una barriera che impedisce il libero movimento delle molecole polari attraverso la membrana. Le parti idrofile, invece, sono rivolte verso l’ambiente idrofilo ai due lati della membrana. In condizioni fisiologiche il doppio strato è fluido, nel senso che le molecole lipidiche sono libere di cambiare posizione e di effettuare determinati movimenti.
Quiz di farmacologia per Esame di Stato (area preclinica)
In questa pagina è possibile esercitarsi su quiz da 10, 25, 50, 100 o 140 domande di farmacologia per l’Esame di Stato, estratte casualmente dall’archivio ufficiale di 390 domande rilasciato dal MIUR. Ogni volta che si ripete un quiz le domande saranno diverse e l’ordine delle risposte mescolato. Ogni domanda presenta 5 possibili risposte di cui 1 sola corretta. Le risposte corrette/errate saranno visualizzate subito dopo aver risposto, nonché al termine del quiz. N.B.: l’Esame di Stato è stato abolito a partire dalla seconda sessione 2019. Per esercitarti su altre materie dell’area preclinica dell’Esame di Stato o per altri quiz, vai qui. Hai riscontrato errori? Invia un messaggio per comunicarlo! Attenzione!…
Polmoni
I polmoni sono gli organi in cui avvengono gli scambi gassosi fra aria e sangue (processo denominato ematosi). In numero di due, destro e sinistro, sono contenuti nelle logge pleuropolmonari della cavità toracica, separati da uno spazio mediano compreso tra la colonna vertebrale e lo sterno, il mediastino, che accoglie cuore, timo, grossi vasi, esofago, trachea e bronchi.
Quiz di farmacologia e tossicologia clinica
In questa pagina è possibile esercitarsi su quiz di farmacologia e tossicologia clinica. Puoi scegliere un test da 10, 25, 50, 100 o 140 domande, estratte da un archivio di centinaia di domande (della stessa disciplina). Ogni volta che si ripete un quiz le domande saranno diverse e l’ordine delle risposte mescolato. Ogni domanda presenta 5 possibili risposte di cui 1 sola corretta. Le risposte corrette/errate saranno visualizzate subito dopo aver risposto, nonché al termine del quiz. Per esercitarti su altre discipline o simulazioni, vai qui. Hai riscontrato errori? Invia un messaggio per comunicarlo! Attenzione! Tutti i quiz possono essere svolti liberamente, senza registrazione al sito. Se si desidera archiviare le prove…