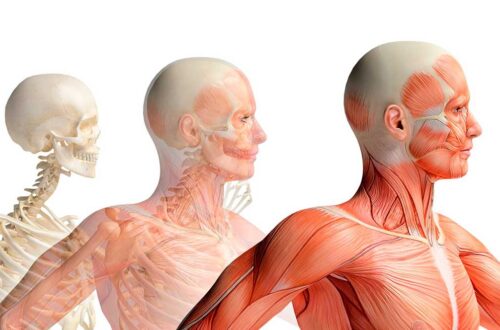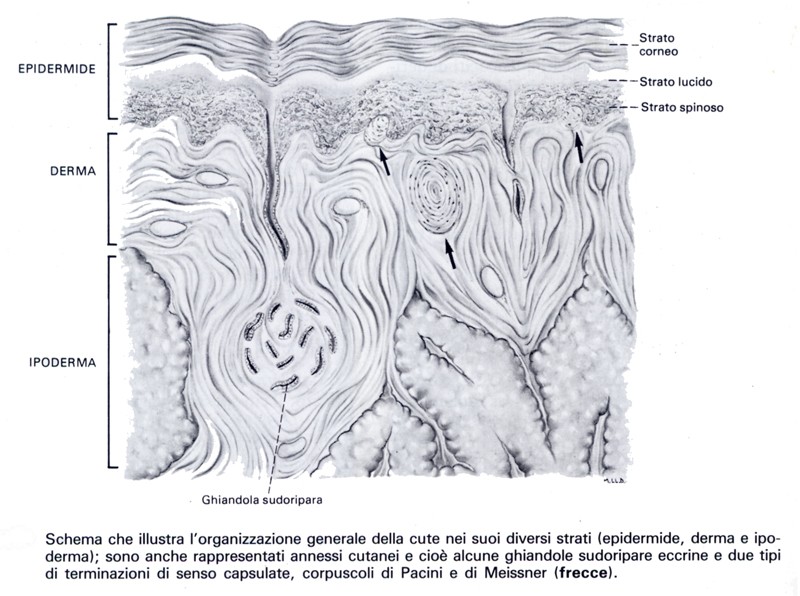Fattori che influenzano l’assorbimento di un farmaco
Per poter giungere nel sangue, il farmaco deve attraversare le cellule, ad esempio quelle della mucosa gastrointestinale in seguito a somministrazione orale. La velocità di assorbimento dipende dalle caratteristiche del farmaco, dalla forma farmaceutica usata e dalle caratteristiche anatomo-fisiologiche della via di somministrazione. Poiché la maggior parte dell’assorbimento del farmaco avviene attraverso processi passivi, l’assorbimento è favorito quando il farmaco è in forma non ionizzata, quindi più lipofila, ossia quanto più è alto il coefficiente di ripartizione lipidi/acqua. I fattori che influenzano l’assorbimento di un farmaco, quindi, sono: pH Ci sono alcuni farmaci che non vengono assorbiti se non a particolari pH, come il carbenoxolone, sostanza usata nell’ulcera gastrica, che…
Recettori
I recettori sono delle strutture glicoproteiche in grado di legare una o più molecole-segnale (o ligandi) come ormoni, fattori di crescita e neurotrasmettitori, e, attraverso una modificazione conformazionale, dare origine a un effetto biologico. Il termine è usato con varie accezioni e in farmacologia, precisamente, corrisponde a qualsiasi struttura biologica bersaglio dei farmaci.
Collettori linfatici dei muscoli peritoracici
Tra i collettori linfatici dei muscoli peritoracici sono soprattutto da ricordare quelli che provengono dal muscolo grande pettorale (per i rapporti che questo muscolo ha con la mammella) e che si portano ai gruppi linfonodali pettorale (o toracico) e sottoclavicolare (o apicale) del linfocentro ascellare. Altri raggiungono i linfonodi sternali. Articolo creato il 6 novembre 2011. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.
Arteria ascellare
L’arteria ascellare è il tronco arterioso principale per l'arto superiore. Dà rami collaterali per alcune formazione della spalla e del torace. Decorre dal margine laterale della 1a costa al margine inferiore del muscolo grande pettorale dove termina continuando con l'arteria brachiale. Insieme ai rami del plesso brachiale e alla vena ascellare attraversa il cavo ascellare, in rapporto con la parete anteriore del cavo stesso che è costituita dal muscolo grande pettorale dietro al quale si trovano la fascia clavicoracopettorale e il muscolo piccolo pettorale.
Sistema nervoso
Il sistema nervoso è un complesso di organi specializzati che hanno la capacità di ricevere e riconoscere stimoli provenienti dagli ambienti esterno ed interno dell’organismo e di elaborare risposte effettrici coordinate di tipo volontario e involontario (attività riflesse). La specifica attività di questi organi si perfeziona nell’uomo con le manifestazioni della sfera psichica.
Papille linguali
In generale, le papille linguali possono essere definite come rilievi, di varia forma, della lamina propria della mucosa sui quali si dispone, seguendone il profilo, l'epitelio di rivestimento. Si descrivono quattro tipi di papille, diverse per numero, forma, distribuzione sul dorso linguale e significato funzionale: papille filiformi (o corolliformi), fungiformi, vallate e foliate.
Struttura del cuore
Le pareti del cuore sono per la maggior parte formate da un particolare tessuto muscolare striato denominato miocardio comune. Nella compagine del miocardio comune si trovano formazioni muscolari specializzate, costituite da miocardio specifico, che si organizzano nel sistema di conduzione del cuore. Il miocardio comune si dispone in fasci che si inseriscono su formazioni fibrose che, nell'insieme, costituiscono lo scheletro del cuore. A questo stesso, sugli anelli fibrosi degli orifizi venosi e arteriosi, prendono attacco i lembi valvolari.
Lesioni viscerali
Le lesioni viscerali sono lesioni contusive (profonde) che si rilevano più spesso nei casi di politraumatismi o comunque a seguito di traumi contusivi di notevole entità. Si tratta di lesioni prodotte al di sotto dello strato adiposo sottocutaneo e determinate da forze di compressione, trazione, torsione, ecc.. Rientrano in questa categoria ernie, lussazioni, ptosi, dislocazioni di organi, lacerazioni parenchimali, nervose e vascolari, ematomi, ecc..
Manicotto (o collare) periostale
Contemporaneamente alle modificazioni della diafisi, e prima che inizi la calcificazione della cartilagine, il pericondrio assume una funzione osteogenica. Alcune cellule dello strato profondo del pericondrio si differenziano in cellule osteoprogenitrici e queste in osteoblasti che depositano attorno alla parte media della diafisi un sottile strato perforato di tessuto osseo, denominato manicotto (o collare) periostale. Quest’ultimo si forma per ossificazione membranosa e diventa progressivamente più spesso via via che l’ossificazione procede.
Sistema afferente (o viscerosensitivo) del parasimpatico
Le fibre afferenti del parasimpatico encefalico hanno la loro cellula d’origine nei gangli sensitivi annessi ai nervi encefalici. Contrariamente ai gangli spinali che raccolgono a un tempo stimoli della sensibilità somatica e viscerale, i gangli sensitivi dei nervi encefalici sono specifici dell’una o dell’altra sensibilità. Unica eccezione è il ganglio genicolato che raggruppa sia protoneuroni della sensibilità viscerale (senso del gusto) sia della sensibilità somatica. Le fibre afferenti del parasimpatico sacrale sono in comune con le corrispondenti fibre ortosimpatiche: come queste ultime hanno il loro centro trofico nei gangli spinali.