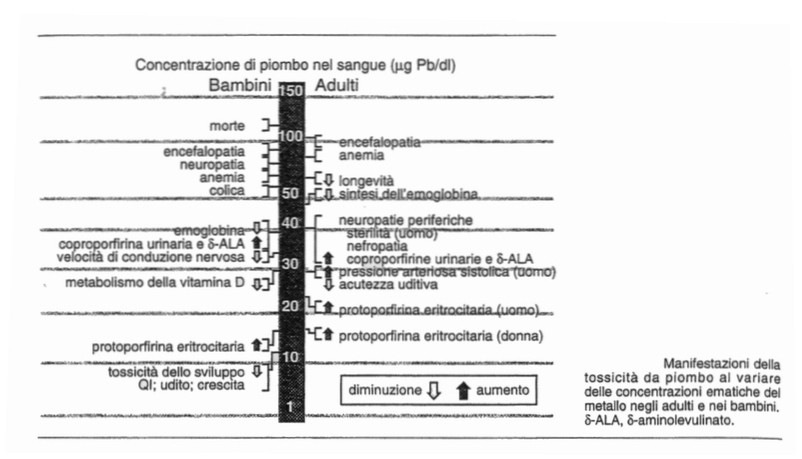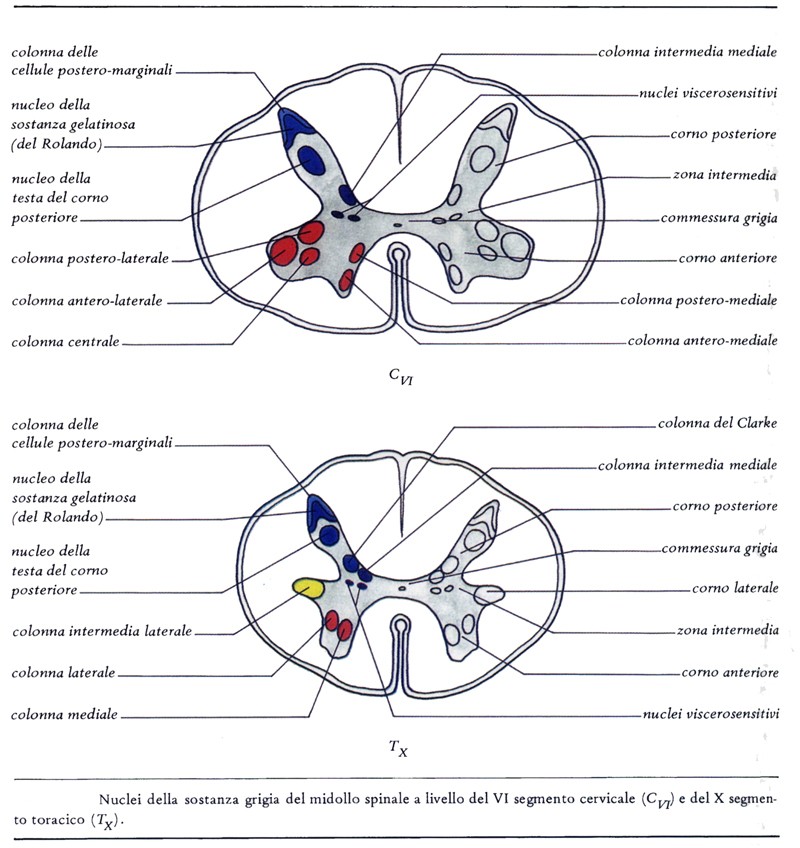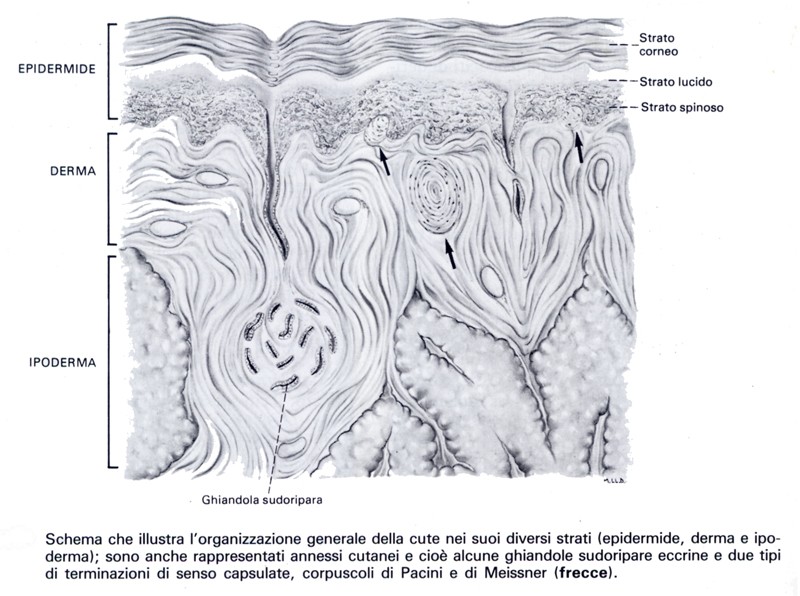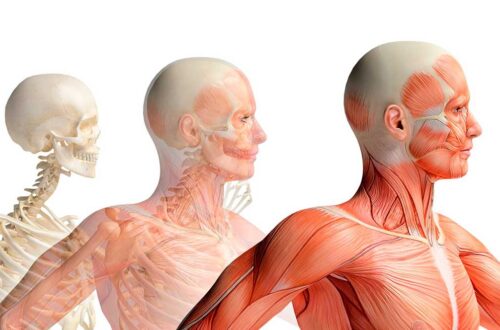Cellule dei coni
Le cellule dei coni sono fotorecettori presenti sulla retina, sensibili alle forme ed ai colori. A differenza delle cellule dei bastoncelli (anch’esse fotorecettori retinici) non garantiscono la visione in condizioni di scarsa luminosità. Negli esseri umani ce ne sono tre tipi: sensibili al rosso, al verde e al blu; se attivati simultaneamente la luce percepita risulta essere bianca. Consentono di percepire dettagli e cambiamenti d'immagine più rapidi rispetto alle cellule dei bastoncelli, poiché i loro tempi di risposta agli stimoli sono più veloci.
Differenza tra infezione e malattia infettiva
L’inizio di un’infezione esogena presuppone l’arrivo di microrganismi patogeni da una sorgente esterna direttamente nel sangue o nei tessuti profondi dell’organismo o, più frequentemente, sulla cute o le mucose.
Corpo vitreo
Il corpo vitreo è un gel chiaro e trasparente, con contenuto d’acqua superiore al 98%, che, nella sua parte periferica, presenta un addensamento impropriamente chiamato membrana ialoidea. Con questa sua parte periferica, più densa, il corpo vitreo si pone in rapporto con la membrana limitante interna della retina, fino all’ora serrata, quindi con il corpo ciliare, con le fibre posteriori della zonula ciliare e infine con la faccia posteriore del cristallino, che viene accolta in un infossamento della sua superficie anteriore, la fossa ialoidea. Il corpo vitreo è attraversato, dall’indietro in avanti, dal canale ialoideo che, partendo dalla papilla del nervo ottico, raggiunge anteriormente il centro della fossa ialoidea. Nella…
Struttura del sistema di conduzione del cuore
Il sistema di conduzione del cuore presenta i seguenti caratteri strutturali.
Metasimpatico
Nella parete dei visceri cavi e nella compagine degli organi parenchimatosi si dimostra un esteso e fine intreccio di fibre viscerali e di ganglietti microscopici che costituiscono il cosiddetto meta simpatico che, ovviamente, rientra nella costituzione del sistema nervoso autonomo (o viscerale o vegetativo o simpatico). Come nelle altre sezioni del sistema nervoso autonomo, le fibre pregangliari dei plessi metasimpatici sono mieliniche, quelle postgangliari sono amieliniche. I gangli del meta simpatico sono costituiti da poche cellule e occupano punti nodali dell’intreccio plessiforme. Nei visceri cavi il metasimpatico è distribuito fra le tonache della parete; nell’apparato digerente, per esempio, esso costituisce il plesso sottomucoso (di Meissner) contenuto nella sottomucosa e il…
Via sottocutanea
La via sottocutanea è una delle vie parenterali con cui può essere somministrato un farmaco. Offre a considerare tempi di assorbimento elevati dovuti ad una scarsa perfusione di questo tessuto. Il ritardo nell’assorbimento potrebbe in alcuni casi portare ad irritazione. Viene utilizzata se si desidera un effetto non troppo elevato e protratto nel tempo. Ad esempio, nella somministrazione dell’insulina bisogna evitare che vi sia un ingresso massivo di insulina che potrebbe causare uno shock ipoglicemico; vi deve essere un arrivo graduale della stessa quantità di insulina con un assorbimento che duri nel tempo. Si può monitorare anche la durata e l’effetto del farmaco andando ad agire sulla molecola e formulandola…
Legamento coronario
Il legamento coronario è il vero legamento sospensore e si estende dalla faccia posteriore del fegato al diaframma. È costituito da due foglietti piuttosto brevi, uno superiore e uno inferiore. Il foglietto superiore è diviso in due porzioni, destra e sinistra, dal legamento falciforme nelle cui due lamine le due porzioni stesse continuano. Il foglietto inferiore nella sua porzione sinistra corre dappresso a quello superiore, nel tratto intermedio circonda la vena cava inferiore in modo caratteristico e si riporta lungo il margine inferiore della faccia posteriore. In questa parte destra della faccia posteriore, le due lamine peritoneali del legamento coronario sono piuttosto distanti (4-5 cm) e la superficie del fegato,…
Ghiandole cardiali
Le ghiandole cardiali fanno parte delle ghiandole gastriche; si trovano nella lamina propria della tonaca mucosa dello stomaco e l’area che occupano si estende per pochi centimetri (0,5-3) a partire dall’orifizio cardiale; tali ghiandole possono trovarsi anche nella mucosa esofagea dove rappresentano un’eterotopia. Le ghiandole cardiali sono del tipo tubulare composto. Le cellule dei tubuli ghiandolari secernono glicoproteine neutre; il loro citoplasma appare pallido, con aspetto finemente schiumoso. Il nucleo si trova nel terzo basale delle cellule, spinto dal secreto. Articolo creato il 24 marzo 2012. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.
Arteria epatica (o gastroepatica)
L’arteria epatica (o gastroepatica) decorre orizzontalmente verso destra e in avanti, passando davanti al pilastro mediale destro del diaframma, dietro la parete posteriore della borsa omentale, sul margine superiore del pancreas. All’altezza del margine superiore della prima porzione del duodeno fornisce l’arteria gastroduodenale e continua verso il fegato con il nome di arteria epatica propria. Passa quindi davanti alla vena porta e risale fra i foglietti del legamento epatoduodenale, accompagnata dalla vena porta e dal dotto coledoco. S’impegna poi come arteria epatica propria nel peduncolo epatico e, in prossimità dell’ilo, si divide al davanti dei rami portali in un tronco destro e uno sinistro. Il ramo destro, di calibro maggiore…
Muscolo elevatore della palpebra superiore
Il muscolo elevatore della palpebra superiore è innervato dal nervo oculomotore. La sua contrazione determina il sollevamento della palpebra superiore. Origina al di sopra dell’anello tendineo, dal margine superiore del foro ottico. Si dirige in avanti, decorrendo sotto al tetto dell’orbita, al di sopra del muscolo retto superiore. Termina con una espansione fibrosa che prende principalmente inserzione sul tarso della palpebra. Articolo creato l’1 ottobre 2012. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.