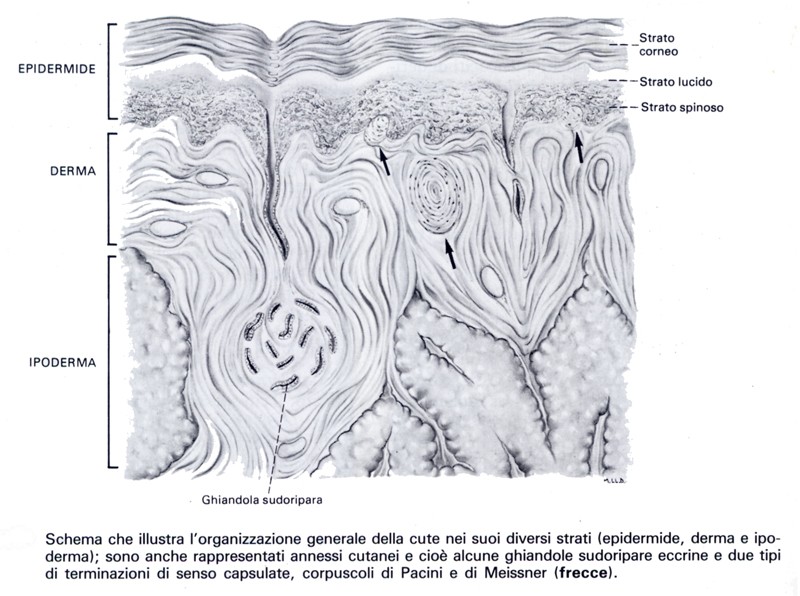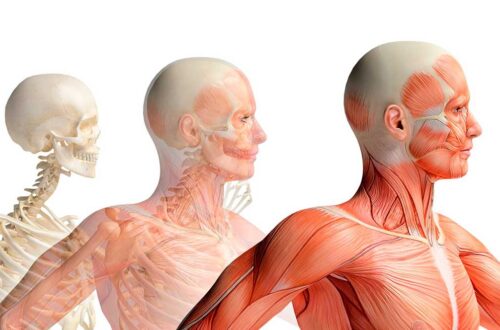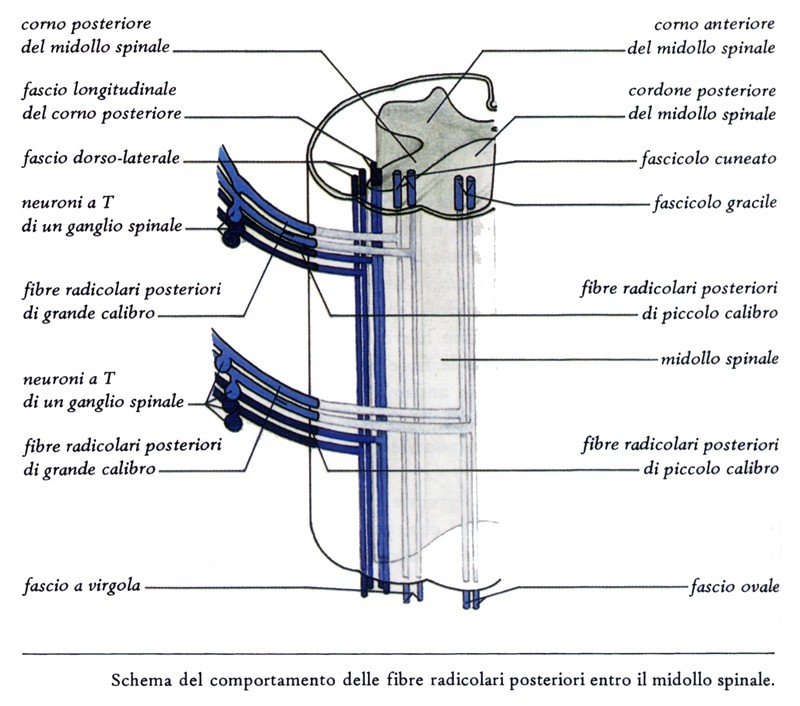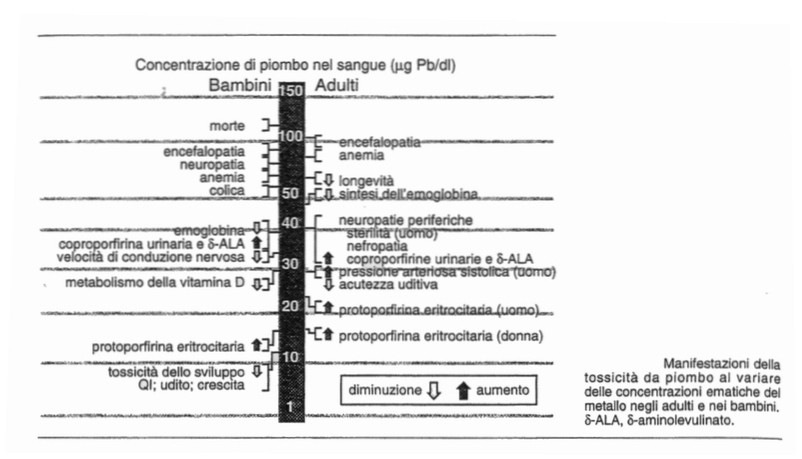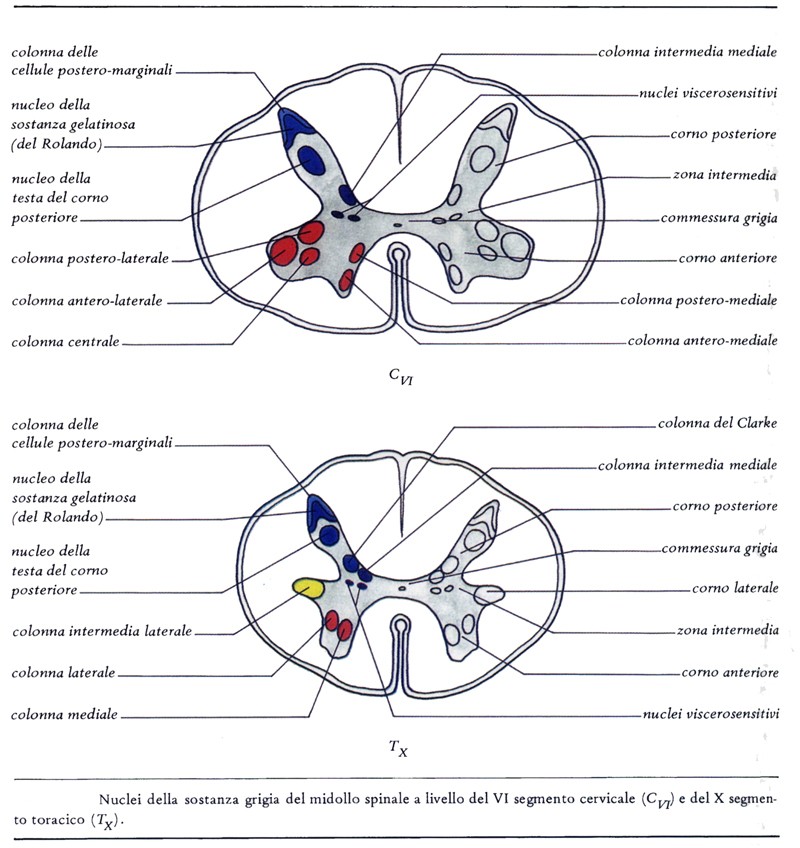Muscolo stiloioideo
Il muscolo stiloioideo è innervato da un ramo del nervo faciale e contraendosi sposta l’osso ioidei in alto e in dietro. Si trova al di sopra e innanzi al ventre posteriore del muscolo digastrico. Origina dal processo stiloioideo, in prossimità della radice, e si porta in avanti, in basso e medialmente, per inserirsi al corpo dell’osso ioide in vicinanza del grande corno. È in rapporto (come ventre posteriore del muscolo digastrico) con il processo mastoideo, con i muscoli sternocleidomastoideo, lunghissimo e splenio della testa, con le ghiandole parotide e sottomandibolare. Articolo creato il 25 febbraio 2010. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.
Struttura del midollo osseo rosso
Come per gli altri organi emopoietici, il midollo osseo rosso presenta uno stroma reticolare, costituito da fibre reticolari argirofile intrecciate a formare una rete a maglie piuttosto strette (reticolo fibrillare), e cellule emopoietiche in vari stadi di differenziamento e dotate di elevata capacità proliferativa, contenute nelle maglie del reticolo e organizzate in nidi e isolotti che costituiscono il parenchima midollare. Lo stroma si addensa intorno ai vasi e si connette all’endostio che tappezza le cavità interne delle ossa. Sono inoltre costantemente presenti cellule endoteliali, fibroblasti, macrofagi e cellule adipose che, nel midollo giallo, occupano la maggior parte del tessuto. Il parenchima midollare è riccamente fornito di vasi che provengono dalle…
Vene sacrali laterali
Le vene sacrali laterali sono due piccoli vasi che decorrono lungo i margini dell’osso sacro. Ricevono le vene intervertebrali della regione sacrale. Formano, insieme con la vena sacrale mediana, il plesso venoso sacrale anteriore. Articolo creato l’8 settembre 2011. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.
Acetilcolina
L’acetilcolina (ACh) è un neurotrasmettitore che esplica i suoi numerosi effetti mediante legame al recettore colinergico muscarinico; essa, comunque, è anche in grado di legare il recettore colinergico nicotinico. L’acetilcolina è secreta dai seguenti neuroni: Nel sistema nervoso centrale: Neuroni del pons dorsolaterale, che hanno numerosi bersagli all’interno del SNC e sono coinvolti nel sonno REM. Neuroni del prosencefalo basale, la maggior fonte di innervazione colinergica di origine corticale, coinvolti nell’apprendimento. Neuroni della regione mediale del setto pellucido, che proietta i suoi assoni soprattutto verso il sistema limbico. Interneuroni dei gangli basali. Nel sistema nervoso periferico: Motoneuroni della via somatica, che provocano la contrazione muscolare scheletrica tramite attivazione dei recettori…
Lesioni personali
Il reato di lesioni personali è disciplinato dall'articolo 582 del Codice penale che sancisce che chiunque cagioni ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione (la durata dipende dal tipo di lesione personale). Il fatto che dall'azione derivi una malattia nel corpo o nella mente differenzia questo reato da quello di percosse per il quale, per definizione, non deve derivare una malattia (al più si deve ridurre ad una reazione dolorosa che non lasci residui funzionali).
Rapporti dei reni
I rapporti del rene, mediati dall'interposizione della capsula adiposa e della fascia renale, posteriormente sono uguali in ambo i lati mentre anteriormente sono diversi a destra e a sinistra. La faccia posteriore del rene è incrociata, circa a metà altezza, dalla 12a costa; si parla pertanto dei rapporti della faccia posteriore del rene al di sopra e al di sotto della 12a costa. Ovviamente il rapporto con la dodicesima costa non è un rapporto diretto perché c’è il diaframma.
Vene dell’organo della vista
Le vene dell’organo della vista raccolgono il sangue refluo dal bulbo oculare e dagli organi contenuti nella cavità orbitaria.
Muscoli lombricali della mano
I muscoli lombricali sono muscoli palmari della mano. I primi due muscoli lombricali sono innervati dal nervo mediano (C6-C8) e gli ultimi due dall'ulnare (C8-T1). Contraendosi, flettono la 1a falange ed estendono la 2a e la 3a falange delle ultime quattro dita.
Medico come ausiliario di polizia giudiziaria
L’articolo 248 del Codice di Procedura Penale prevede il medico come ausiliario di polizia giudiziaria, la quale può incaricare il medico a svolgere un’attività obbligatoria (rifiutandosi, il medico potrebbe incorrere nel reato di rifiuto di atti legalmente dovuti secondo l’articolo 366 del Codice di Procedura Penale) e gratuita. In questa sede il medico assume la qualifica di Pubblico Ufficiale ed è tenuto all’obbligo del segreto d’ufficio (che è diverso e più importante del segreto professionale). Le attività che possono essere richieste al medico possono essere: Ispezione di cadavere. Ispezione personale. Perquisizione personale. Queste attività possono essere richieste a qualunque medico, non necessariamente uno specialista in medicina legale. Il medico non…
Plesso celiaco
È un plesso impari facente parte del sistema nervoso ortosimpatico. Si estende al davanti dell’aorta, nel tratto compreso fra l’arteria celiaca e l’arteria mesenterica superiore. È formato da gangli di considerevoli dimensioni e da un intreccio di fibre di varia provenienza e natura. Ai lati dell’arteria celiaca sono situati due gangli, pari e simmetrici, di forma irregolarmente semilunare, denominati gangli celiaci (o gangli semilunari). Hanno dimensioni pari a quelle di un fagiolo, colore grigiastro e disposizione quasi orizzontale; i contorni sono irregolari in quanto a essi mettono capo numerose fibre del plesso celiaco. Il ganglio di destra, in aggiunta alle altre afferente ortosimpatiche, riceve al suo polo laterale il nervo…