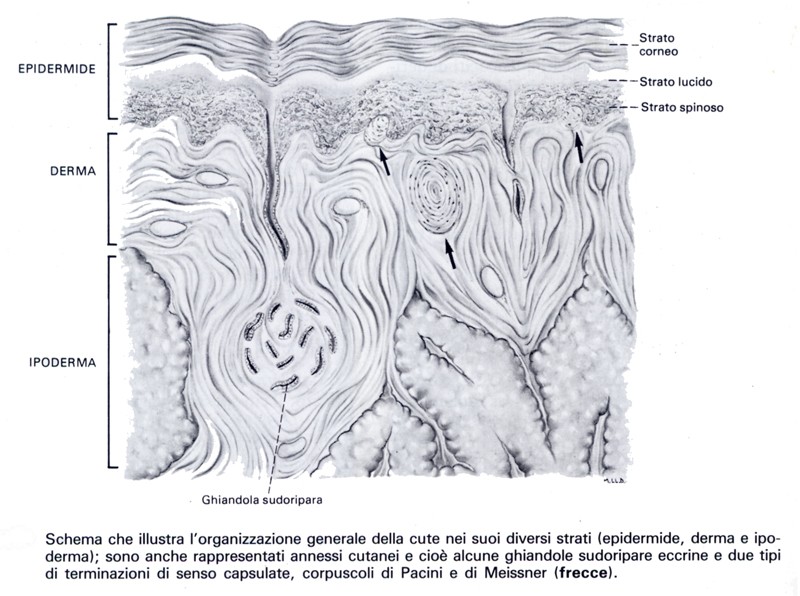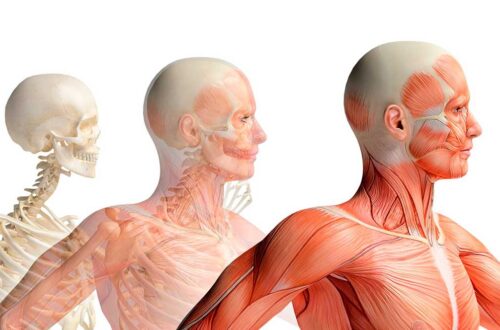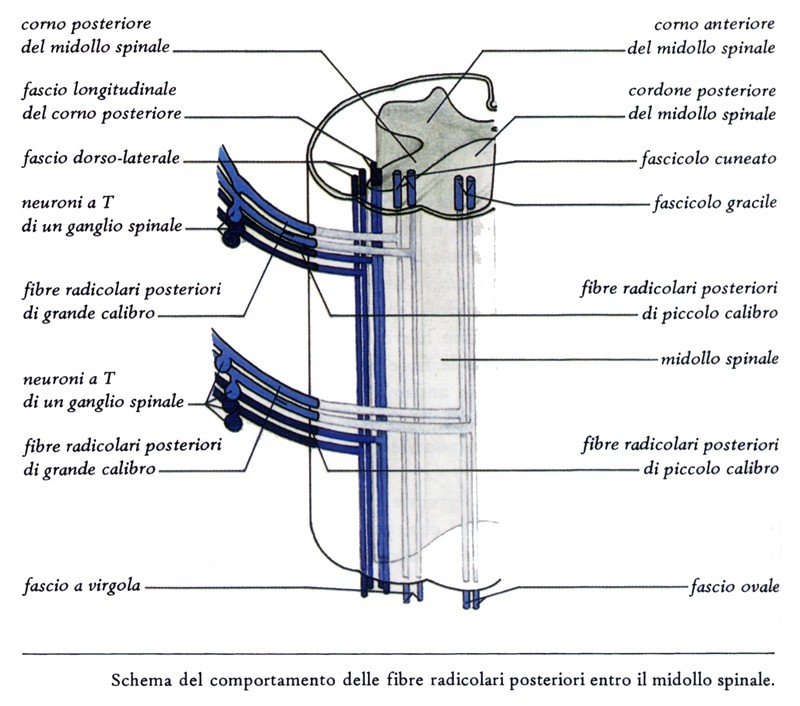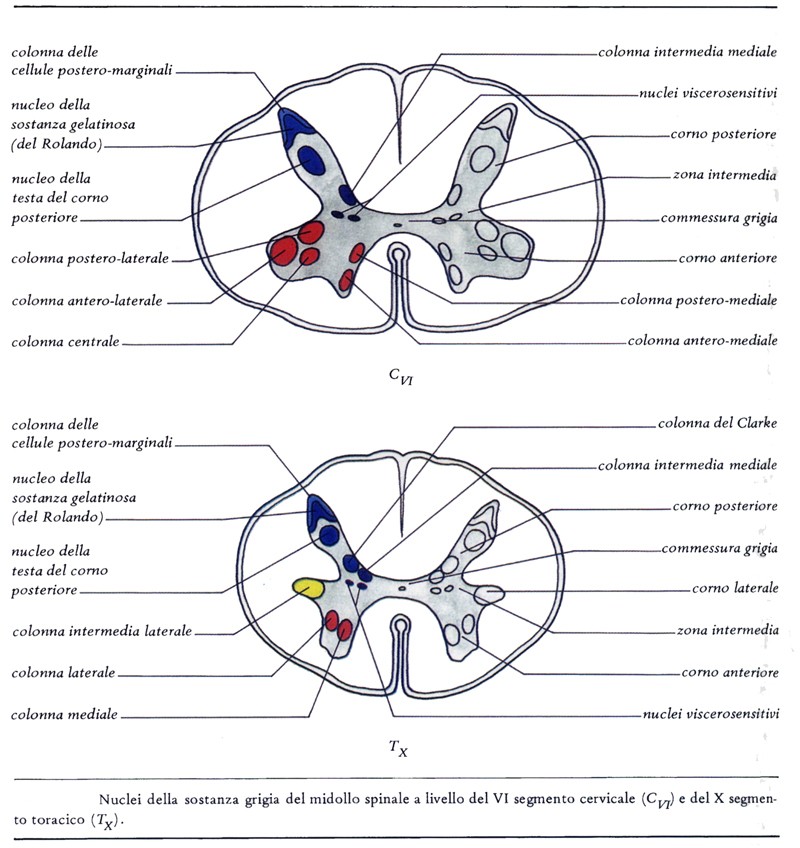Articolazioni metatarso-falangee
Le articolazioni metatarso-falangee sono articolazioni condiloidee, analoghe alle metacarpo-falangee della mano. Ciascuna articolazione è circondata da una capsula articolare, rinforzata da un legamento plantare e da legamenti collaterali. Articolo creato il 18 aprile 2010. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.
Ghiandole endocrine unicellulari
Una serie di elementi cellulari capaci di produrre sostanze attive di tipo ormonale, e che riconoscono alcune caratteristiche comuni, tali da poterle inquadrare in un unico sistema, costituiscono il così detto sistema endocrino diffuso (o sistema APUD).
Area sottesa alla curva concentrazione plasmatica-tempo
L’area sottesa alla curva concentrazione plasmatica-tempo (AUC) è il parametro farmacocinetico che informa circa l’esposizione sistemica dopo somministrazione di un farmaco. Essa è utilizzata per la misurazione della biodisponibilità. Per misurare l’area sottesa alla curva si può utilizzare la scomposizione della curva in trapezi. Misurando l’area di ciascun trapezio e sommandole si avrà la biodisponibilità. Articolo creato il 26 agosto 2010. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.
Struttura del corpo ciliare
La superficie interna del corpo ciliare è rivestita dalla parte ciliare della retina, che risulta costituita da uno strato più esterno di cellule pigmentate e da uno strato più interno di cellule cilindriche, prive di pigmento, simili per struttura alle cellule dei plessi corioidei. Queste cellule, secernenti e a stretto contatto fra di loro, tramite numerosi desmosomi, e con le cellule pigmentate dello strato sottostante, concorrono alla produzione dell’umore acqueo. Articolo creato il 16 settembre 2012. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.
Sistema efferente (o visceroeffettore) del parasimpatico
Mentre nel sistema nervoso periferico somatico l’impulso effettore è trasmesso alla periferia da un solo neurone (motoneurone somatico) che dal nevrasse si porta senza interruzione fino all’organo innervato, nel sistema ortosimpatico (come nell’ortosimpatico) la trasmissione degli impulsi effettori si svolge tramite una catena di due neuroni: un neurone primario (o pregangliare o presinaptico) origina nei centri nervosi nevrassiali del tronco encefalico e nei segmenti caudali del midollo spinale e termina in sinapsi con un neurone secondario (o postgangliare o postsinaptico), situato in un ganglio. Il neurone secondario, a sua volta, manda le sue fibre alle sedi periferiche di innervazione viscerale. In genere il rapporto tra neuroni pregangliari e postgangliari è…
Fibula (o perone)
La fibula (o perone) è un osso lungo, più sottile della tibia rispetto alla quale è laterale, formato da un corpo e da due estremità. Il corpo è rettilineo e ha forma prismatica triangolare. La faccia laterale è liscia, salvo che al centro dell’osso dove si riscontra una depressione destinata ad accogliere i muscoli peronieri laterali. La faccia mediale è percorsa da un rilievo verticale, la cresta interossea dove prende inserzione la membrana interossea della gamba. La faccia posteriore è rugosa per varie inserzioni muscolari. I tre margini sono sottili e taglienti. L’estremità superiore presenta una faccetta articolare piana, volta in alto e medialmente, in giunzione con la faccetta articolare…
Struttura della papilla ottica
Nella papilla ottica si trovano soltanto le fibre nervose che ivi convergono provenendo da tutte le cellule multipolari della retina; tutti gli altri strati mancano completamente. Le fibre, amieliniche, si rivestono di guaina solo dopo aver attraversato la lamina cribrosa della sclera. Articolo creato il 16 settembre 2012. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.
Mesi dello spazio sottomesocolico
Una volta terminati i vari accollamenti peritoneali, alcuni tratti del tubo digerente conservano un meso. Se i visceri non esistessero, il peritoneo si disporrebbe in modo regolare sulla parete addominale posteriore così come fa su quella anteriore. Incontrando però i peduncoli di diversi organi, esso li avvolge, continuando nel foglietto viscerale. Si è già descritto altrove il mesocolon trasverso; restano dunque da prendere in considerazione, nello spazio sottomesocolico, il mesentere, il mesoappendice e il mesocolon ileopelvico. Si tratta di doppie lamine peritoneali che sottendono, e fissano a parete, l’intestino tenue, l’appendice e il colon ileopelvico. Articolo creato il 21 agosto 2011. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.
Ormone di liberazione dell’ormone tireotropo (TRH)
L’ormone di liberazione dell’ormone tireotropo (TRH) è un neuropeptide costituito da soli tre aminoacidi che viene sintetizzato dai neuroni ipotalamici del nucleo paraventricolare; immagazzinato nell’eminenza mediana, sotto adeguato stimolo viene immesso nelle vene portali ipofisarie e raggiunge le cellule bersaglio rappresentate dalle cellule dell’adenoipofisi che secernono l’ormone tireotropo (o tireotropina, TSH) e la prolattina. Meccanismo d’azionedell’ormone di liberazione dell’ormone tireotropo Nell’ipofisi, esso si lega a recettori della membrana citoplasmatica determinando l’ingresso di calcio e l’aumento dei prodotti di idrolisi del fosfatidilinositolo, che rappresentano, pertanto, i secondi messaggeri. A questo punto l’ormone tireotropo (o tireotropina o TSH) viene secreto con meccanismo esocitico. L’ormone di liberazione dell’ormone tireotropo può essere utilizzato come…
Vene di tipo recettivo
Le vene di tipo recettivo sono rappresentate dalle vene dei territori sopradiaframmatici e in particolare dalle vene della testa e del collo e anche da alcune vene dell'arto superiore e dei distretti viscerali. Hanno parete poco spessa di tipo fibroso. La tonaca intima (è il nome della tonaca mucosa nei vasi sanguigni) è formata dall'endotelio e da uno strato di connettivo fibroso contenente esili reti di fibre elastiche. La tonaca media (è il nome della tonaca muscolare nei vasi sanguigni) è rappresentata da una tessitura di fibre collagene con scarse fibre elastiche e rare cellule muscolari a direzione circolare.